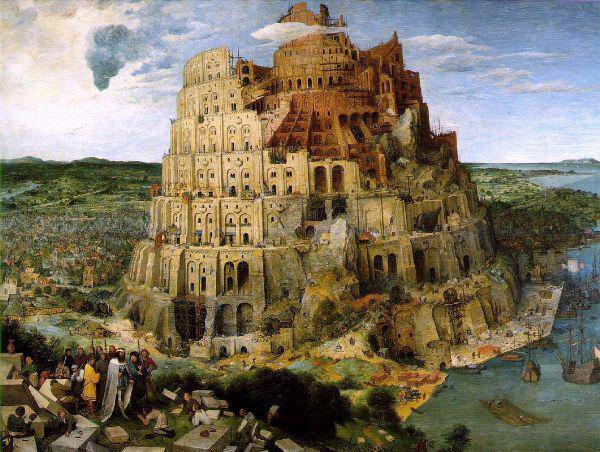Per quanto possa sforzarmi di tornare indietro con la memoria, il ricordo del termine “superbia” mi riporta sempre, a quando ero bambino e la mente fissò il nome di Tarquinio il Superbo. Tutto ruota intorno alla sua persona, di cui conosco ben poco, eppure la qualifica è quanto rimane in me del personaggio. Non saprei dire perché mi colpì così tanto da permanere come pensiero nella memoria. Forse, perché con lui si concludeva la lista dei re di Roma che eravamo obbligati, già in tenera età, a imparare a memoria come una filastrocca; forse, perché neppure sapevo cosa fosse la superbia, ma il termine rimbombante lo imponeva… saranno gli psichiatri a determinare il tutto. Ciò che posso dire è che parlando di superbia il nome del re Tarquinio è il primo che balza alla mente. Certo, non senza ragione i Romani gli affibbiarono l’appellativo se è vero, come attesta Tito Livio, che convocato il Senato ed entrato nella Curia si sedette sul seggio del re; questi accorso sul posto magna voce gli intimò: “Quid hoc, Tarquini, rei est? qua audacia me vivo vocare ausus es patres aut in sede considere mea?”. Ciò che Servio Tullio chiamava giustamente audacia, i Romani poco alla volta la definirono superbia, sperimentandola sulla loro pelle.
Qualunque sia il ricordo, comunque, non è di Tarquinio che dobbiamo parlare, ma di noi in relazione a ciò che è identificato come l’origine di tutti i vizi. Da qualsiasi parte ci si volta, infatti, la superbia sembra avere il primato. Per chi vuole trattare dei vizi rispettando l’ordine alfabetico: accidia, avarizia, gola, invidia, ira, lussuria, arriva alla superbia come il culmine di un procedere. Per quanti vogliono modificare l’ordine, la prima che viene nominata è sempre lei, la superbia, per incarnare ciò che rappresenta. Il “peccato capitale”, così chiamato per primo da Gregorio Magno e tematizzato in seguito dalla teologia medievale, e in primis da Tommaso d’Aquino, porta con sé tanti derivati che impediscono di innalzarsi a una corretta vita di relazioni e di ordine cosmico. Sono sette, come si sa, per indicare secondo la cabala la pienezza e la totalità di una vita ripiegata sul male.
Ironia della sorte, però, la semantica del termine (ύπερηφανία) è positivo. Pur nell’etimologia oscura, il significato originario intende esprimere il carattere “eminente”, “eccellente” e “insigne” dell’animo umano e della sapienza. Lo sviluppo successivo, al contrario, venne usato in senso peggiorativo e riprovevole come “arroganza”, “vanteria” e “alterigia”. Insomma, per gli antichi Greci, la superbia si colloca tra la ύβρις, tipica di chi disprezza e la αλαζών, il presuntuoso millantatore che inganna se stesso ed è un ciarlatano vantando pregi che non ha. In una parola, il superbo è un folle presuntuoso, perché si vanta della sua posizione, del potere e della ricchezza guardando gli altri sprezzantemente dall’alto in basso. In una parola, il termine manifesta un’esperienza universale. Nell’uomo di ogni terra e di ogni cultura, in ogni tempo e lingua si verifica il segno di una connotazione giudicata negativamente perché tesa a dominare sul proprio simile e a disprezzare le doti altrui. E così, la letteratura greca antica è densa di riferimenti che mettono in guardia dalla superbia e da ultimo, soprattutto per influsso degli stoici, il superbo venne incluso nei cataloghi dei vizi.
Prima di entrare nel merito della superbia, non sarà inutile anticipare qualche riflessione sul perché la Chiesa ha identificato sette peccati capitali e perché li ha chiamati così. Una considerazione importante è fatta dal Catechismo il quale dice che: “Il peccato trascina al peccato; con la ripetizione dei medesimi atti genera il vizio. Ne derivano inclinazioni perverse che ottenebrano la coscienza e alterano la concreta valutazione del bene e del male” (ccc 1865). Insomma, la lotta tra il bene e il male permane fino alla fine dei tempi. Certo, è impari. Come attesta l’apostolo Paolo le “opere della carne” e il “frutto dello Spirito” (Cfr Gal 5,19-23) non stanno sullo stesso livello. La forza redentrice di Cristo ha vinto e ha distrutto il peccato del mondo, ma la libertà degli uomini, che segna l’originalità del cristianesimo, permane come la conditio sine qua non. “Dio che ti ha creato senza di te, non ti salva senza di te”. L’espressione di sant’Agostino permane con la sua forza di significato per indicare l’imporsi della libertà personale. Mai, probabilmente, il dramma della libertà si esprime con tutta la sua potenza come nella scelta tra il bene e il male e nella vita a servizio dell’uno o dell’altro. Vivere nel bene apre il cuore e rende fecondi; scegliere il male impoverisce e rinchiude in se stessi. Certo, rimarrà sempre la grande quaestio di cosa sia bene e male; eppure, nel profondo del cuore di ognuno, e impresso nelle pagine della natura, il confine posto non è solo percepito, ma anche compreso e tematizzato. Il male, comunque, offusca la coscienza e la discesa diventa sempre più scoscesa e scivolosa. C’è una ambivalenza nel vizio che tende a nascondere la parte peggiore, per illudere con il canto delle sirene. Dall’altra parte, c’è la forza della virtù che chiama al bene. Perseverare nel bene crea virtù che consente non solo di compiere atti positivi, ma soprattutto sprona a dare il meglio di sé e a ricercare forme sempre più grandi di bene. Ecco, pertanto il dramma: dove c’è il vizio, là c’è la virtù che si contrappone: a te la scelta. Sei posto dinanzi all’orientamento da dare alla tua vita. A te la scelta di quale ruolo vuoi giocare. Da ogni parte ti volti, comunque, non puoi rimanere neutrale.
Probabilmente, oggi il vizio ha un fascino maggiore della virtù. Già il nome di virtù appare obsoleto e riservato a una piccola categoria che diventa fastidiosa e da evitare perché non ci consentirebbe di vivere la vita come vogliamo. Il vizio, invece, no. Del vizio preferiamo intesserne le lodi. In qualche modo, ci piace e ci affascina; ci consente di sperimentare il brivido del proibito che la Chiesa ha sempre combattuto per tenerci legati e soggiogati a sé. E poi, il vizio si traveste felicemente con il tratto ironico che ti rende simpatico anche il peccato peggiore. Chi non riesce a trovare simpatia per un impareggiabile Alberto Sordi nelle vesti dell’Avaro? L’avaro Sordi, fa ridere della sua avarizia e non permette più di cogliere il male intrinseco di chi vuole accumulare solo per sé. E così, ancora una volta, sembra avere ragione Molière: “Tutti i vizi, quando sono di moda, passano per essere una virtù”.
Dall’accidia alla superbia, e viceversa, il passo è breve. Soprattutto ai nostri giorni non è difficile percepire come la presenza dell’una conduca inesorabilmente all’altra. Il fatto non è innocuo per la vita personale. L’accidia, o l’ozio, è stata normalmente identificata come il vizio dei monaci. Indica, l’atteggiamento di indifferenza e disinteresse per il mondo, la vita, se stessi. Spesso si accompagna con la stanchezza, la noia, l’apatia e lo scoraggiamento, portando di fatto alla malattia dei nostri tempi: la depressione. Non si è più padroni di sé, si pensa che il groviglio dell’esistenza sia un labirinto senza via d’uscita e ci si rinchiude in una totale forma di sfiducia. E, tuttavia, non si può confondere la patologia con il vizio. Se c’è vizio allora c’è scelta e quindi responsabilità. Vivere stancamente e nell’ozio, riempire le giornate di pettegolezzo e mirare solo alle debolezze degli altri per non guardare a noi stessi, rimuginare rancore e malizia nei rapporti… insomma, tutto questo porta a dimenticare l’esperienza di Dio e del suo amore. Il passo verso la superbia è breve. Dimentico di Dio non resta che l’uomo, anzi rimango solo io! La superbia, in ultima analisi, è il rifiuto di Dio. Lui o io. Non può esserci una via di mezzo.
Lo aveva ben compreso Agostino quando nel De civitate Dei dice perentoriamente che la superbia è “allontanarsi da Dio e convertirsi a sé” (12,6). Il superbo, scimmiotta Dio; perché vuole imitare la sua potenza e rendersi simile a lui. Non è un caso, quindi, che egli veda nella superbia “l’origine di tutti i mali perché è la causa di tutti i peccati” (In Ioh ev 25,16); tanto da poter “sussistere anche da sola senza gli altri peccati” (De nat et gr 29,33). Torna con tutto il suo valore l’accenno all’etimologia; quel ύπερ dice tutto. Indica il mettersi sopra gli altri, il non voler vedere nessun altro se non se stessi. Una grande lezione proviene anche da Tommaso che, non si dimentichi, è la fonte per Dante come vedremo subito. Con la profondità che gli è propria, Tommaso dice che: “La superbia è il vizio e il peccato con il quale l’uomo, contro la retta ragione, desidera andare oltre la misura delle sue condizioni” (STh II-II,162,1). L’analisi di questa espressione consente di vedere il nucleo della superbia. Il superbo, di fatto, crea una sproporzione tra sé e la realtà con la conseguenza che la volontà, principio che guida l’agire, non è più capace di giudicare coerentemente. Ecco perché è contraria alla retta ragione perché il superbo sopravvaluta se stesso senza confrontarsi con la realtà. La superbia diventa, di fatto, un andare contro la ragione. Questa è fatta per ricercare la verità, vale a dire, ciò che è coerente (adequatio); con la superbia, invece, la stessa ragione è fuori strada. Dirà sempre Tommaso: “I superbi mentre godono della propria superiorità, trovano fastidio nella superiorità della verità” (II-II,162,3, Concl). Non si tratta più di solo sentimento o di condizione psicologica caratteriale. La superbia è un uso non corretto della ratio! Ciò implica l’assunzione di una responsabilità che proviene da una scelta fatta. Puntare gli occhi sulla verità, al contrario, crea equilibrio e permette di vedere non solo la complessità della realtà, ma il suo ordine intrinseco verso cui siamo orientati per ottenere il bene.
Ne è ben consapevole Dante, che alla scuola di Tommaso, identifica esempi concreti di superbi nell’XI canto del Purgatorio. Non è privo di significato che il canto X sia un inno all’umiltà per far emergere il valore della virtù dinanzi al vizio. Alla stessa stregua, l’inizio del canto si apre con la preghiera del Padre nostro per far emergere il riconoscimento dell’uguaglianza dei figli di Dio dinanzi all’unico Padre. Come si sa, Virgilio indica al poeta i superbi come coloro che “La grave condizione di lor tormento a terra li rannicchia… si vede giugner le ginocchia al petto, così fatti vid’ io color, quando puosi ben cura”. Tre personaggi ricurvi su se stessi camminano sotto il peso del masso che li opprime. L’immagine è limpida fin dall’inizio: coloro che si sono sopravvalutati ora sono schiacciati a tal punto da non poter vedere neppure Dante che passa accanto a loro. Omberto Aldobrandeschi, Oderisi da Gubbio e Provenzano Salvani stanno a indicare i tre ambiti in cui la superbia sembra esercitarsi con maggior facilità: la nobiltà, l’arte e la politica. Il primo si rivolge a Dante chiedendo, retoricamente, e con un accenno alla superbia non ancora debellata, se lo ricorda. Il secondo, invece, è riconosciuto dal poeta che si china fino a terra per poterlo vedere in volto. E’ con lui che il dialogo diventa più intenso e il senso della superbia acquista maggior significato. “Oh vana gloria de l’umane posse!” esclama Oderisi, facendo da eco a Gregorio Magno che proprio così aveva definito la superbia: “inanis gloria”. La superbia altro non è che illusione e transitorietà: “com’ poco verde in su la cima dura”. Lui, il grande e insuperabile artefice di miniature, ora si vedeva superato dal Bolognese di cui non aveva voluto riconoscere l’arte in vita. Alla stessa stregua, parla di Cimabue superato da Giotto, e Guido Guinizzelli che fu dimenticato per il sorgere del Cavalcanti. E, come lascia intuire il testo, anche costui a sua volta adombrato dalla grandezza di Dante. Ed infine, il capo dei ghibellini di Siena votato alla damnatio memoriae al sopraggiungere della vittoria dei guelfi. Insomma, insegna Dante, la superbia ti illude, perché è effimera. Ti lascia godere un istante, ma a ben vedere ti abbandona presto e rende la delusione ancora più grande.
Torna con forza, a questo punto, un’immagine anch’essa scolpita nella mia mente di ragazzo quando davanti al televisore seguivo l’incoronazione di Paolo VI. Il Papa sulla sedia gestatoria procedeva contento e salutava festoso una folla che lo acclamava. Ad un certo punto, il cardinale con in mano un piatto ricolmo di ovatta, incurante di quanto accedeva chiamò il Papa: “Pater Sancte”. Paolo VI si volse verso di lui e in quel momento il cardinale diede fuoco all’ovatta: “Sic transit gloria mundi”. Un attimo e il fuoco bruciò tutto. Il volto di Paolo VI divenne greve e pensoso. Il segno, in questo caso, parla molto di più delle parole. Nessuno può gloriarsi perché tutto passa velocemente, e solo puntare all’essenziale crea stabilità.
Dio disperde quanti hanno pensieri di superbia perché si contrappongono a lui e rimangono chiusi in se stessi e nell’illusione della loro arroganza, mentre egli esalta l’umile. Non è un caso che soprattutto i libri sapienziali facciano ricorso alla dialettica tra superbia e umiltà per indicare in quest’ultima la via privilegiata a cui il giusto e il pio devono attenersi. E’ significativo, d’altronde, che il vangelo di Marco, ripercorrendo lo stesso pensiero, ponga la superbia tra la “bestemmia” e la “stoltezza”; cioè è tipico dello stolto essere superbo, perché si rivolta contro Dio, non volendo riconoscere la sua grandezza, ma nello stesso tempo condanna se stesso per non avere un’intelligenza adeguata della sua esistenza (Mc 7,22). Una parabola, comunque, acquista in questo contesto tutto il suo valore. Gesù narra di due uomini, un fariseo e un pubblicano che si ritrovano insieme al tempio per la preghiera. Il primo, “stando in piedi, pregava così tra sé: O Dio, ti ringrazio, che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo” (Lc 18,11-12). Aver posto l’esempio del superbo nello scenario della preghiera ha un suo primo significato: come ci si pone dinanzi a Dio, così ci si pone dinanzi agli uomini, e viceversa. Il senso della parola, comunque, non verte sulla preghiera, ma sull’atteggiamento dell’uomo davanti a Dio. Come si vede, il fariseo fa riferimento a due fatti; anzitutto, elenca i peccati da cui si tiene lontano, poi riferisce di tutte le sue opere buone. Ciò che egli fa è riconosciuto solo come sua impresa personale; il tono delle sue parole e il vanto che ne deriva non sono altro che un’autoesaltazione e compiacenza di sé a tal punto da non essere neppure sfiorato dal pensiero che potrebbe essere un peccatore. Insomma, la sua preghiera diventa un monologo per pronunciare il giudizio su se stesso; non deve attendere quello di Dio, perché si è già posto come innocente davanti a lui e ha trovato il capro espiatorio: il pubblicano. Alla fine, poiché compie opere che non sono comandate dalla legge, ma sono compiute per la sua buona volontà, egli è perfino creditore nei confronti di Dio, a differenza del povero pubblicano che neppure ha la forza di alzare gli occhi verso di lui e chiedere il suo perdono. L’amore di Gesù, tuttavia, è nei confronti di quest’ultimo che nella sua condizione umile di peccatore riconosce di avere bisogno dell’amore di Dio. La verità sulla propria vita appartiene al pubblicano, non al fariseo che rimane fermo nel suo inganno: “Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi” (1 Gv 1,8).
A conclusione di questa riflessione giunge attuale la parola di Gregorio Magno. Nel suo Commento morale a Giobbe, il grande Papa identifica quattro atteggiamenti che permettono di riconoscere la superbia: “Quando si pensa che il bene derivi da noi stessi; quando si crede che, se ci viene dato dall’alto, è per i nostri meriti; quando ci si vanta di avere ciò che non si ha; quando, disprezzando gli altri, si aspira ad apparire gli unici dotati di determinate qualità… Tutto ciò che fanno gli altri, anche se è fatto bene, non piace all’orgoglioso; gli piace solo ciò che fa lui, anche se è fatto male. Disprezza sempre le azioni degli altri e ammira sempre le proprie perché, qualunque cosa faccia, crede di aver fatto una cosa speciale e in ciò che fa, pensa per bramosia di gloria al proprio tornaconto; crede di essere in tutto superiore agli altri e mentre va rimuginando i suoi pensieri su di sé, tacitamente proclama le proprie lodi. Qualche volta poi è talmente infatuato di sé che quando si gonfia si lascia pure andare a discorsi esibizionisti” (33,16-34,48). A ben vedere, l’immagine che ne deriva del superbo è piuttosto una caricatura in cui cade l’uomo. In un momento in cui il narcisismo ha conquistato un posto d’onore nella cultura dei nostri giorni e in molti dei nostri comportamenti, una seria considerazione su chi siamo realmente non dovrebbe stonare né apparire fuori luogo. Perdere il senso del limite e non essere più capaci di humor su se stessi conduce a quella ipertrofia dell’ego che presto o tardi porta a conseguenze nefaste per la propria vita. Meglio allargare l’orizzonte e puntare sull’essenziale della vita per consentire di raggiungere quella vera libertà fonte di genuina realizzazione di sé. Dovremo dire con il libro dei Proverbi: “Ubi humilitas ibi sapientia” (11,2). La verità su se stessi proviene dalla capacità di ascolto e di gratuità che sostengono la profonda intelligenza in ricerca della verità ultima.
MONS. RINO FISICHELLA